(2) Pallas
Posizione Attuale
| Coordinate locali | Alt.: -51,19° Az: 351,69° |
| Coordinate geocentriche | AR: 22:02:50,14 Dec: -03°16,264 |
| Costellazione: | Aqr |
| Eventi: | Levata: 07:43 Culm.: 13:34 Tramonto: 19:25 |
| Dist.Terra: | 4,16 UA |
| Dist.Sole: | 3,27 UA |
| Diametro: | 0'' |
| Magnitudine: | 10,19 |
(2) Pallas è il secondo asteroide in ordine di scoperta e uno dei più grandi oggetti nella fascia principale tra Marte e Giove. La sua storia, le sue caratteristiche fisiche e la sua orbita peculiare lo rendono un oggetto di grande interesse scientifico.
Storia della scoperta e classificazione
La scoperta di Pallas avvenne il 28 marzo 1802 ad opera dell'astronomo tedesco Heinrich Wilhelm Olbers da Brema. Olbers stava cercando di riosservare Cerere, il primo asteroide scoperto l'anno precedente, per permettere il calcolo preciso della sua orbita. Fu per puro caso che, osservando nella zona settentrionale della costellazione della Vergine, notò una "stellina" di settima magnitudine che non era segnata sulle mappe stellari dell'epoca. Seguendo questo oggetto per alcune ore, ne confermò il movimento e realizzò di aver scoperto un nuovo corpo celeste. Lo battezzò "Pallade", un epiteto legato alla dea greca Atena.
Come accadde per Cerere e gli altri asteroidi scoperti nei primi anni del XIX secolo, Pallas fu inizialmente considerato e classificato come un pianeta, completo di un simbolo astronomico dedicato (spesso un quadrato o triangolo sormontato da una croce). Questa classificazione rimase in uso finché il crescente numero di scoperte di corpi simili portò alla creazione di una nuova categoria: quella degli "asteroidi" o "pianetini".
Dimensioni e forma: una storia di misure variabili
La determinazione delle dimensioni di Pallas fu oggetto di dibattito tra gli astronomi del XIX secolo, con stime iniziali molto divergenti. William Herschel stimò un diametro di circa 238 km, mentre l'astronomo tedesco Johann Hieronymus Schröter arrivò a una stima ben quattordici volte maggiore, pari a 3.380 km. Sebbene inizialmente si pensasse potesse essere più grande di Vesta, le stime successive si attestarono su valori molto più contenuti, oscillando intorno ai 490 km.
Oggi, grazie a tecniche osservative più avanzate, sappiamo che Pallas non è perfettamente sferico ma ha una forma triassiale. Le misurazioni più accettate indicano dimensioni approssimative di 570 km x 525 km x 500 km, con un diametro medio di circa 539 chilometri. Questo lo rende il terzo oggetto più massiccio nella fascia principale, dopo Cerere e Vesta.
Caratteristiche fisiche e composizione
Pallas ha una magnitudine assoluta di circa 4.3 e compie una rotazione sul proprio asse in circa 10 ore. Il suo albedo geometrico è di circa 0.1587, il che significa che riflette circa il 16% della luce solare incidente. Sebbene non sia scuro come la Luna (albedo 0.07), è significativamente meno riflettente di Venere (albedo 0.65).
Analisi spettroscopiche indicano che la sua superficie è composta prevalentemente da silicati ricchi di ferro e magnesio, con una composizione che presenta alcune somiglianze con quella di Cerere, ma anche differenze significative. Queste caratteristiche lo collocano nella categoria degli asteroidi di tipo B, che si ritiene contengano materiale primitivo e alterato dall'acqua.
Con una massa stimata di circa 2.11×1020 kg, la sua densità media è di circa 3.4±0.9 g/cm³.
Un'orbita inclinata e una famiglia di asteroidi
L'orbita di Pallas è piuttosto insolita per un grande asteroide della fascia principale. Sebbene si trovi nella fascia principale, la sua orbita è fortemente inclinata rispetto al piano medio delle orbite della maggior parte degli altri asteroidi, con un valore di circa 34.8°. Inoltre, presenta una notevole eccentricità (circa 0.23). Compie una rivoluzione attorno al Sole in circa 4.6 anni, raggiungendo una distanza minima di circa 2.11 UA (perielio) e una massima di circa 3.42 UA (afelio).
Questa inclinazione elevata fa sì che Pallas attraversi il piano orbitale della fascia principale con un angolo significativo, rendendo le interazioni gravitazionali e le potenziali collisioni diverse rispetto agli asteroidi che orbitano più vicino al piano.
Proprio lo studio delle orbite di Pallas e di altri asteroidi portò l'astronomo giapponese Kiyotsugu Hirayama, all'inizio del XX secolo, a identificare gruppi di asteroidi con parametri orbitali simili, suggerendo un'origine comune da eventi collisionali. Pallas è il membro più grande e il corpo eponimo della famiglia di asteroidi Pallade, un gruppo di asteroidi con orbite altamente inclinate che si ritiene siano frammenti di impatti passati su Pallas.
Una superficie sfregiata e una storia violenta
Le immagini più dettagliate della superficie di Pallas sono state ottenute grazie a osservazioni avanzate da terra, come quelle del Very Large Telescope (VLT) dell'ESO, pubblicate nel 2020. Queste immagini ad alta risoluzione hanno rivelato una superficie estremamente craterizzata, al punto da essere paragonata a una "pallina da golf". Sono stati identificati numerosi crateri, molti dei quali con diametri superiori ai 30 chilometri, che coprono almeno il 10% della superficie visibile. Questa elevata densità di crateri testimonia una storia collisionalle violenta e intensa. Si ritiene che l'orbita inclinata di Pallas lo esponga a impatti ad alta velocità con altri oggetti della fascia principale, che possono causare danni maggiori rispetto a collisioni tra corpi con orbite meno inclinate.
Tra le caratteristiche superficiali osservate, spiccano un punto particolarmente luminoso nell'emisfero meridionale, che potrebbe essere un deposito di sali brillanti, e un vasto bacino da impatto vicino all'equatore, forse risultato di una collisione con un corpo già frammentato.
Visibilita annuale di (2) Pallas
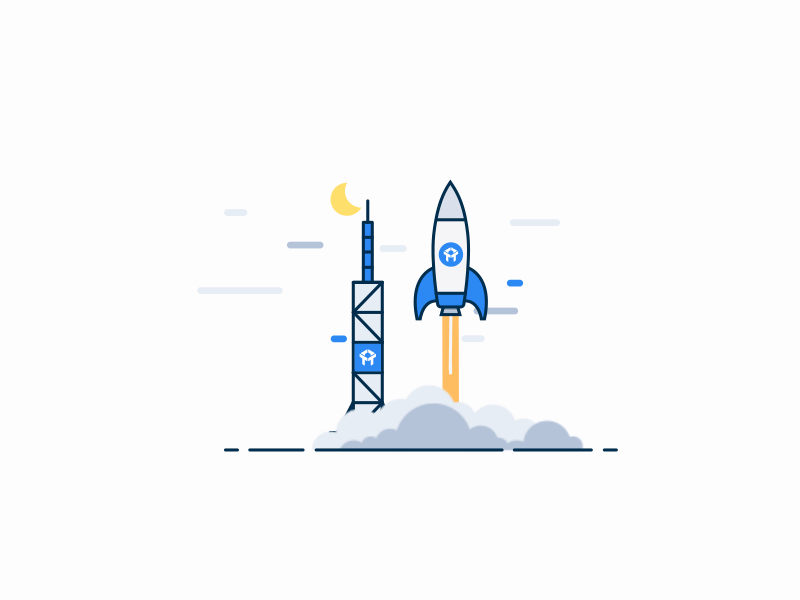
Calcolo Effemeridi mensili
| Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
|---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Levata: - Culm.: - Tramonto:
| Orario | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
|---|

 Chi Siamo
Chi Siamo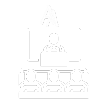 Terra in Vista 2024
Terra in Vista 2024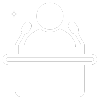 Relatori
Relatori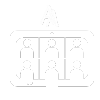 Argomenti
Argomenti WebTV
WebTV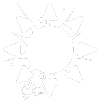 Sole
Sole Luna
Luna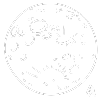 Strutture lunari
Strutture lunari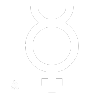 Mercurio
Mercurio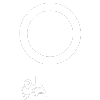 Venere
Venere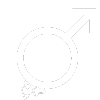 Marte
Marte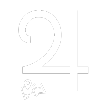 Giove
Giove Satelliti di Giove
Satelliti di Giove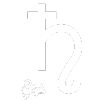 Saturno
Saturno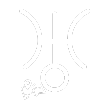 Urano
Urano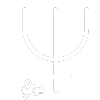 Nettuno
Nettuno Asteroidi
Asteroidi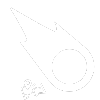 Comete
Comete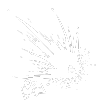 Bolidi
Bolidi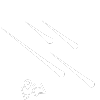 Sciami meteorici
Sciami meteorici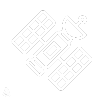 ISS
ISS Altri satelliti
Altri satelliti Lanci
Lanci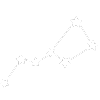 Costellazioni
Costellazioni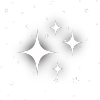 Stelle
Stelle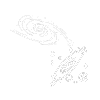 Profondo cielo
Profondo cielo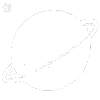 Esopianeti
Esopianeti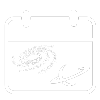 Cielo del mese
Cielo del mese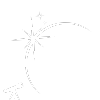 Eclissi di Sole
Eclissi di Sole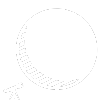 Eclissi di Luna
Eclissi di Luna