(4) Vesta
Posizione Attuale
| Coordinate locali | Alt.: -50,18° Az: 68,93° |
| Coordinate geocentriche | AR: 20:50:25,03 Dec: -19°53,785 |
| Costellazione: | Cap |
| Eventi: | Levata: 07:34 Culm.: 12:22 Tramonto: 17:10 |
| Dist.Terra: | 3,21 UA |
| Dist.Sole: | 2,22 UA |
| Diametro: | 0'' |
| Magnitudine: | 8,66 |
(4) Vesta è il quarto asteroide scoperto e uno degli oggetti più grandi e scientificamente importanti della fascia principale tra Marte e Giove. Considerato un protopianeta, Vesta offre uno sguardo unico sulle primissime fasi di formazione del Sistema Solare.
La scoperta e il contesto storico
La scoperta di Vesta avvenne in un periodo di grande fermento astronomico. Dopo la scoperta di Cerere nel 1801, e quelle successive di Pallade e Giunone, gli astronomi erano attivamente alla ricerca di altri corpi celesti nella regione tra Marte e Giove, spinti in parte dall'idea di un pianeta "perduto" o distrutto in quella zona, come suggerito dalla Legge di Titius-Bode. Fu in questo clima di ricerca che Heinrich Wilhelm Olbers, lo stesso astronomo che aveva scoperto Pallade, individuò Vesta il 29 marzo 1807 mentre osservava nella costellazione della Vergine. La sua scoperta fu in parte fortuita, ma si inseriva perfettamente nel contesto della ricerca dell'epoca.
Olbers affidò i dati orbitali a Carl Friedrich Gauss, il celebre matematico, che ne calcolò l'orbita. Fu Gauss a suggerire il nome "Vesta", in onore della dea romana del focolare domestico, riconoscendo implicitamente la sua importanza. Come i corpi minori scoperti in precedenza, Vesta fu inizialmente classificato come un pianeta, ricevendo il simbolo astronomico dedicato e la designazione (4) Vesta. Questa classificazione persistette per decenni prima che la crescente popolazione di oggetti simili portasse alla definizione della categoria degli asteroidi.
Dimensioni, massa e caratteristiche fisiche
Vesta è il secondo asteroide per massa e il terzo per dimensioni (dopo Cerere e Pallade) nella fascia principale. Ha una forma leggermente irregolare, con un diametro massimo di circa 578 chilometri. La determinazione precisa delle sue dimensioni fu un processo graduale, con stime iniziali molto variabili (come quelle di Herschel e Schröter) che furono affinate solo in tempi molto più recenti grazie a metodi come l'osservazione dei transiti stellari e le misurazioni dirette della sonda spaziale Dawn.
La sua massa è stimata in circa 2.59×1020 kg, il che rappresenta circa il 9% della massa totale della fascia principale. Dalla massa e dalle dimensioni si deriva una densità media di circa 3.4 g/cm³.
Vesta è l'asteroide più luminoso visibile dalla Terra, raggiungendo una magnitudine apparente che varia tra 5.4 (nei momenti di maggiore vicinanza e favorevole illuminazione) e 8.5 (quando è più distante). In condizioni ottimali di opposizione, la sua magnitudine si attesta intorno a 6.5, rendendolo visibile anche con un semplice binocolo da luoghi con cielo scuro. Per distinguerlo dalle stelle fisse, è necessaria una mappa celeste dettagliata o un'osservazione prolungata per rilevarne il movimento.
La sua temperatura superficiale varia drasticamente a seconda dell'illuminazione solare, oscillando tra circa -20°C nelle zone illuminate e circa -190°C nelle zone in ombra. Vesta ruota sul proprio asse in circa 5.3 ore.
Orbita
Vesta orbita attorno al Sole nellafascia principale con un periodo di circa 3.63 anni. La sua orbita presenta un perielio a circa 2.15 UA e un afelio a circa 2.57 UA. La sua velocità orbitale media è di circa 19.4 km/s.
Struttura interna, composizione e superficie
Gran parte della nostra conoscenza dettagliata di Vesta deriva dalla missione spaziale Dawn della NASA. Lanciata nel 2007, la sonda Dawn ha raggiunto Vesta nel luglio 2011 e ha orbitato attorno all'asteroide per circa un anno, fino a luglio 2012, prima di proseguire il suo viaggio verso Cerere. Durante la sua permanenza, Dawn ha raccolto una quantità enorme di dati e immagini, rivoluzionando la nostra comprensione di questo corpo celeste.
I dati della missione Dawn e l'analisi di meteoriti trovate sulla Terra e identificate come provenienti da Vesta (le meteoriti HED: Howarditi, Eucriti e Diogeniti) hanno confermato che Vesta è un corpo differenziato. Ciò significa che, analogamente ai pianeti terrestri, presenta una struttura interna stratificata: un nucleo metallico ricco di ferro e nichel, un mantello composto principalmente da silicati come l'olivina e una crosta basaltica. Questa differenziazione implica che Vesta ha subito un processo di fusione interna poco dopo la sua formazione, probabilmente a causa del calore generato dal decadimento di isotopi radioattivi a breve vita.
Vesta si è formato molto precocemente nella storia del Sistema Solare, accrescendosi rapidamente in circa 3 milioni di anni dalla stessa nebulosa primordiale che ha dato origine al Sole e ai pianeti. La sua composizione elementare riflette in larga misura le abbondanze cosmiche iniziali. L'analisi delle meteoriti HED ha fornito preziose informazioni sulla composizione e sulla storia magmatica della crosta e del mantello di Vesta, indicando un'attività vulcanica che potrebbe essere durata per almeno 30 milioni di anni dopo la formazione.
Nonostante le conferme sulla sua struttura differenziata, i dati di Dawn hanno anche sollevato nuove domande e messo in discussione alcuni modelli preesistenti, in particolare riguardo allo spessore degli strati interni e alla distribuzione di alcuni elementi come l'olivina. La scarsa quantità di olivina esposta nel gigantesco cratere Rhea Silvia, contrariamente alle attese basate su modelli di crosta più sottile, ha portato a ipotizzare una crosta più spessa del previsto o che l'olivina osservata in superficie possa provenire dal corpo impattante piuttosto che dal mantello di Vesta. Queste evidenze suggeriscono una storia evolutiva più complessa e forse eventi collisionali inaspettati.
La superficie di Vesta è segnata da una miriade di crateri da impatto, testimonianza della sua lunga e turbolenta storia nella fascia principale. La caratteristica più imponente è il gigantesco cratere Rhea Silvia, situato vicino al polo sud. Con un diametro di circa 505 chilometri, è così vasto da coprire circa il 90% dell'intero diametro dell'asteroide, presentando una profonda depressione e un picco centrale elevato. Si ritiene che questo cratere sia stato formato da un impatto violentissimo avvenuto miliardi di anni fa, un evento così energetico da aver espulso nello spazio una quantità significativa del materiale di Vesta, che ha poi dato origine alla famiglia di asteroidi Pallade e alle meteoriti HED che cadono sulla Terra.
Un'altra caratteristica notevole sono i profondi solchi che circondano l'equatore di Vesta, a formare una sorta di "cintura". Studi basati su simulazioni di impatto suggeriscono che questi solchi siano il risultato dell'onda d'urto prodotta dall'impatto che ha creato Rhea Silvia, propagatasi attraverso l'interno dell'asteroide e riaffiorata sulla superficie a grande distanza dal punto d'impatto.
Indizi di acqua e materiale extrasolare:
I dati di Dawn e l'analisi di meteoriti Vestiane hanno anche fornito prove della presenza passata e forse attuale di acqua su Vesta. Sebbene la superficie sia arida oggi, la rilevazione di idrogeno da parte dello strumento GRaND (Gamma Ray and Neutron Detector) a bordo di Dawn suggerisce la presenza di ghiaccio d'acqua nel sottosuolo, specialmente nelle regioni in ombra permanente. Studi recenti, utilizzando tecniche radar bistatiche, hanno ulteriormente supportato l'ipotesi di ghiaccio subsuperficiale.
La presenza di acqua è anche suggerita dall'analisi di alcune meteoriti HED, in particolare le eucriti, la cui composizione isotopica dell'acqua è sorprendentemente simile a quella dell'acqua sulla Terra, supportando l'idea che asteroidi carbonacei ricchi di acqua possano aver bombardato sia la Terra che Vesta nelle prime fasi del Sistema Solare, portando acqua su entrambi i corpi.
Inoltre, l'analisi di alcune meteoriti provenienti da Vesta ha rivelato la presenza di polvere stellare, materiale risalente a tempi precedenti la formazione del nostro Sistema Solare, incorporato in Vesta durante la sua accrescimento o durante eventi collisionali successivi. La composizione isotopica di queste inclusioni indica interazioni tra roccia e acqua, suggerendo che l'acqua possa essere stata trasportata su Vesta anche da micrometeoroidi ghiacciati.
Temperatura e proprietà termiche
Le misurazioni termiche effettuate dallo spettrometro italiano VIR-MS a bordo di Dawn hanno fornito la prima mappa termica dettagliata di Vesta. Queste osservazioni hanno rivelato una bassa inerzia termica media sulla superficie, indicando che la temperatura del suolo cambia rapidamente in risposta all'irraggiamento solare. Tuttavia, è stata osservata una significativa diversità nelle proprietà termiche tra le diverse regioni della superficie, che potrebbe essere correlata a differenze nella composizione del suolo, nelle dimensioni delle particelle della regolite (lo strato di materiale incoerente che copre la superficie) o nella storia di esposizione agli agenti spaziali. L'analisi dell'emissione termica ha anche suggerito una stratificazione del terreno, con una densità che aumenta con la profondità. Le variazioni di luminosità osservate sulla superficie non dipendono solo dalla composizione del materiale (come la contaminazione da asteroidi carbonacei scuri) ma anche dall'angolo di illuminazione e osservazione.
Un protopianeta fondamentale per la Scienza:
Vesta è considerato un protopianeta perché ha subito i processi di differenziazione interna che caratterizzano i pianeti, ma la sua crescita si è interrotta prima di raggiungere le dimensioni planetarie. È l'unico corpo ampiamente intatto di queste dimensioni a mostrare una differenziazione completa. La sua sopravvivenza e la sua struttura interna ed esterna forniscono un "fossile" eccezionale per studiare le condizioni e i processi fisici e chimici che hanno avuto luogo nei primissimi milioni di anni di vita del Sistema Solare. L'analisi dei dati di Dawn e lo studio continuo delle meteoriti Vestiane sono fondamentali per svelare i misteri della formazione planetaria e dell'evoluzione dei corpi celesti.
Visibilita annuale di (4) Vesta
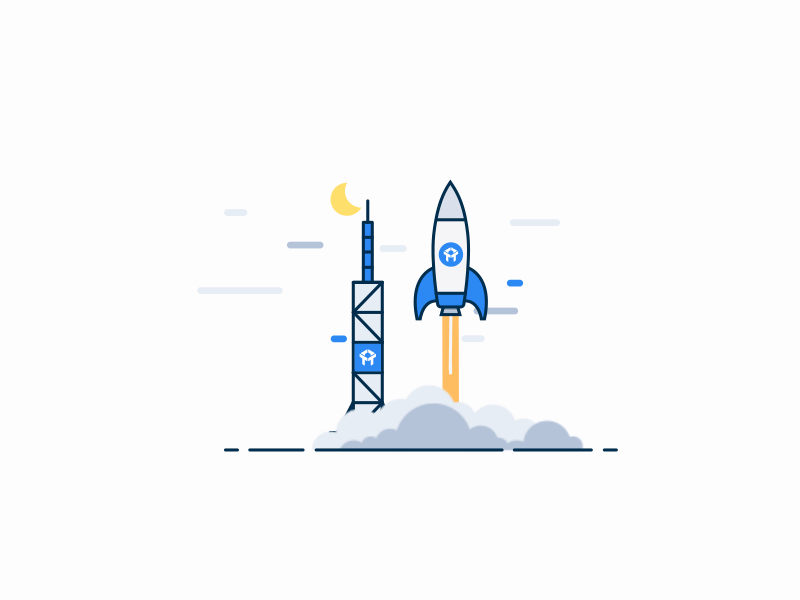
Calcolo Effemeridi mensili
| Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
|---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Levata: - Culm.: - Tramonto:
| Orario | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |
|---|

 Chi Siamo
Chi Siamo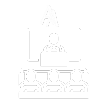 Terra in Vista 2024
Terra in Vista 2024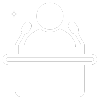 Relatori
Relatori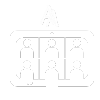 Argomenti
Argomenti WebTV
WebTV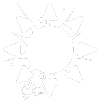 Sole
Sole Luna
Luna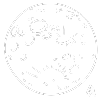 Strutture lunari
Strutture lunari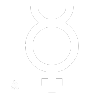 Mercurio
Mercurio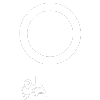 Venere
Venere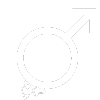 Marte
Marte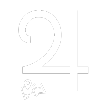 Giove
Giove Satelliti di Giove
Satelliti di Giove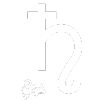 Saturno
Saturno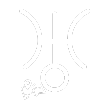 Urano
Urano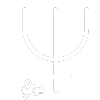 Nettuno
Nettuno Asteroidi
Asteroidi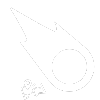 Comete
Comete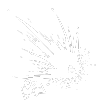 Bolidi
Bolidi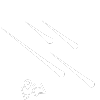 Sciami meteorici
Sciami meteorici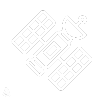 ISS
ISS Altri satelliti
Altri satelliti Lanci
Lanci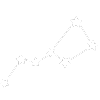 Costellazioni
Costellazioni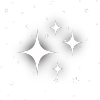 Stelle
Stelle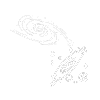 Profondo cielo
Profondo cielo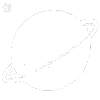 Esopianeti
Esopianeti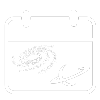 Cielo del mese
Cielo del mese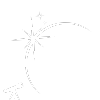 Eclissi di Sole
Eclissi di Sole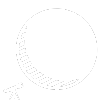 Eclissi di Luna
Eclissi di Luna