Orion
| Nome | Orione |
| Genitivo | Ori |
| Abbreviazione | Ori |
| Estensione (gradi^2) | 594 |
| Emisfero | AUSTRALIS |
| Confini |
|
| Stagionalità |
|
|
|
|
| Eventi: |
|
| Altezza: | 16,523° |
| Azimut: | 98,184° (E) |
Il nome, la storia, il mito
La costellazione di Orione, una delle più brillanti e riconoscibili del cielo notturno, è da millenni al centro di miti e leggende in diverse culture. Le sue stelle brillanti come Betelgeuse e Rigel e l'asterismo della Cintura ne disegnano il profilo inconfondibile, celebrato sin dall'antichità. Ma Orione non è solo una figura astronomica: è un personaggio mitologico la cui storia si intreccia con leggende, poemi epici e opere d’arte, dall’antica Grecia fino ai giorni nostri.
Il mito greco
La figura mitologica di Orione nasce nella Grecia antica, ma come spesso accade, esistono molte versioni della sua storia.
Nel De Astronomia di Igino, Orione è un gigante (in termini di altezza e non di appartenenza ai Giganti che attaccarono le sedi olimpiche), un cacciatore di straordinaria bellezza e abilità, figlio del dio del mare Poseidone e della ninfa Euriale (in altre versioni è figlio di Gea, la Terra). Grazie all’eredità divina, Orione può camminare sulle acque, simbolo del suo legame con il mare e il cielo, anche se in realtà questa caratteristica non sembra legata alla possibilità di non affondare ma all'altezza, in grado di fargli attraversare l'oceano riuscendo sempre a toccare il fondale con i piedi. La sua abilità nella caccia era leggendaria, tanto da vantarsi di poter uccidere qualsiasi animale sulla Terra.
Proprio questa superbia lo portò a scontrarsi con Gea (secondo altri, con la dea Artemide, protettrice della natura e degli animali selvatici). Diverse versioni del mito narrano la fine di Orione. In Igino, Gea invia uno scorpione a pungere il cacciatore, uccidendolo con il suo veleno mortale. Zeus, colpito dalla bellezza e dalla forza di Orione, lo trasformò in una costellazione vicina alle Pleiadi (legame con un'altra versione che vedremo a breve), permettendogli di continuare la sua caccia tra le stelle.
Questa è la ragione per cui le costellazioni di Orione e dello Scorpione sono opposte nel cielo: quando le stelle dello Scorpione sorgono ad Est, Orione sconfitto tramonta ad Ovest; il ciclo si completa quando lo scorpione, tramontando ad Ovest, viene schiacciato dall'Ofiuco, Esculapio, che così facendo resuscita il cacciatore, che rinasce ad Est, rinnovato.
 Selene ed Endimione La morte di Orione, 1660s-1670s · Johann Karl Loth
Selene ed Endimione La morte di Orione, 1660s-1670s · Johann Karl Loth
Secondo una versione dalle sfumature più accattivanti, Orione approdò nell' isola di Creta per dilettarsi nella caccia di animali dei quali cui sentì parlare e che abitavano solo nell'isola. Imbattutosi in Artemide, che ben conosceva la fama di quel cacciatore, ella non rimase indifferente al suo fascino e dal momento che condividevano la medesima passione, lo invitò ad andare a caccia insieme. Apollo, fratello della dèa, mostrò di esserne geloso e volle tutelarla, temendo per la sua virtù e giudicando Orione un approfittatore. Riferì alla madre di Artemide, Gea, che Orione si vantava delle sue abilità di cacciatore, e di come avesse affermato essere in grado di sterminare tutte le belve che vivevano sulla terra. Infuriata, Gea fece uscire dalla terra un gigantesco e mostruoso scorpione a cui ordinò di uccidere col suo veleno il cacciatore. Si giunse allo scontro. Orione provò a uccidere la bestia scoccando frecce, ma queste non scalfirono lo scorpione. Impugnò allora la sua spada, ma fu vano, e messo alle strette, si buttò in mare per fuggire e raggiungere a quel punto l'isola di Delo. Ma avvistato in lontananza da Apollo, questi convinse Artemide che fosse un furfante e fece credere alla sorella si trattasse di un certo Candaone che aveva sedotto una delle sue sacerdotesse, Opide, e subito la invitò a punirlo, trafiggendolo con una delle frecce della sua faretra. La dèa, senza sapere che in realtà Candaone era il nomignolo con il quale veniva chiamato in Beozia (sua terra natìa) Orione, prese la mira e lo trafisse. Ma accortasi dell'errore, si buttò in mare, raggiunse il corpo e lo trascinò a riva. Disperata supplicò l'intervento di medico Esculapio, esprimendo il desiderio che questi lo riportasse in vita grazie alle sue note arti mediche. Ma mentre si apprestava ad esaudire la volontà di Artemide, Zeus fulminò il guaritore a morte. Per Orione non ci fu nulla da fare. Rassegnata Artemide decise di trasportare l'immagine del cacciatore fra le stelle.
Orione e Merope
Secondo una delle versioni più diffuse del mito, Orione si innamora di Merope, figlia del re Enopione. La storia di Orione e Merope è raccontata principalmente da Pseudo-Apollodoro (Biblioteca, I, 4, 3) e in parte di nuovo da Igino (De Astronomia, II, 34). Esistono nuovamente diverse versioni, spesso discordanti nei dettagli, ma la base narrativa rimane simile: Orione si innamora di Merope e chiede al padre di sposarla. Tuttavia, gli eventi prendono una piega drammatica. Nella Biblioteca, Apollodoro narra che Orione, innamorato di Merope, si presenta al re Enopione, sovrano di Chio, per chiedere la sua mano. Il re, però, impone condizioni difficili, rimandando continuamente la promessa del matrimonio. Orione, ubriaco e infuriato per i continui rifiuti, tenta di usare la forza per ottenere ciò che desidera.
 "Paysage avec Orion aveugle cherchant le soleil" di Nicoulas Poussin. 1658, Metropolitan Museum of Art di New York
"Paysage avec Orion aveugle cherchant le soleil" di Nicoulas Poussin. 1658, Metropolitan Museum of Art di New York
In alcune versioni, Orione viene catturato da Enopione dopo il tentativo di violenza e subisce una terribile punizione: il re lo acceca e lo abbandona. Dopo essere stato accecato, Orione si dirige verso oriente insieme a Cedalione, operaio della fucina di Efesto, il dio fabbro, seguendo la profezia che la luce del sole avrebbe potuto restituirgli la vista. Secondo alcune versioni, egli si reca sull’isola di Lemno, dove viene guarito dal dio Efesto o da Helios (il Sole). Una volta riacquistata la vista, Orione cerca vendetta contro Enopione, ma non riesce a trovarlo, perché il re si è nascosto in un rifugio sotterraneo costruito dagli dèi.
Igino fornisce una versione simile, soffermandosi sulla fuga di Enopione e sul desiderio di vendetta di Orione. Non menziona il tentativo di violenza su Merope, ma enfatizza la punizione e la cecità dell’eroe.
Una nascita particolare
Ancora Igino (Favole) fornisce una nascita di Orione molto particolare, tirando in ballo tre divinità e fornendo una spiegazione al nome "Orione", che effettivamente deriva dal graco urein (urinare o eiaculare). Il re Irieo di Tracia invitò Giove, Nettuno e Mercurio nella propria casa e in cambio i tre dei decisero di esaudire un desiderio del re. Questi chiese di avere dei figli e così Mercurio scuoiò il toro che era stato immolato per loro e, all'interno di questa pelle, i tre dèi orinarono. Sotterrarono poi nella Terra il tutto (la Terra, quindi Gea) e proprio da questo gesto nacque Orione.
Orione e altre mitologie
Il tema della morte e della rinascita richiamerebbe una più antica concezione: cinque piramidi della quarta dinastia nella Piana di Giza in Egitto sembrano disposte in modo da rappresentare una parte della costellazione di Orione, col fiume Nilo come Via Lattea. Il condotto d'aria meridionale della grande piramide è allineato alle stelle della cintura di Orione, in particolare a zeta Ori, nella posizione del 2700- 2600 a.C. A quel tempo la costellazione rappresentava il dio egizio della morte e primo faraone d'Egitto, Osiride. Si narra che dopo la morte il faraone abbia misticamente inseminato queste stelle affinché, attraverso Osiride, il dio- Sole Horus potesse rinascere come suo successore.
Per i Maya, Orione era una figura centrale nella loro cosmologia. La costellazione era associata al dio della creazione e della guerra, ed era legata a importanti eventi astronomici e rituali.
 "Diane auprès du cadavre d'Orion", di Daniel Seiter - 1685 - Museo del Louvre, di Daniel Seiter - 1685 - Museo del Louvre
"Diane auprès du cadavre d'Orion", di Daniel Seiter - 1685 - Museo del Louvre, di Daniel Seiter - 1685 - Museo del Louvre
Osservazione
Estesa 594 gradi quadrati e con 120 stelle più brillanti della sesta magnitudine, rintracciare la costellazione di Orione è tra i compiti più semplici grazie a tre stelle perfettamente allineate che formano la 'cintura' del guerriero, nota proprio come 'cintura d'Orione'. La sua forma prevede spalle, piedi e appunto la famosa cintura, formata da tre stelle in diagonale. Attaccata alla cintura c'è la spada del cacciatore, contenente la famosa Grande Nebulosa di Orione.
La Cintura di Orione, conosciuta anche come il Balteo di Orione, è quindi un asterismo facilmente riconoscibile nella costellazione di Orione ed è una delle figure più iconiche del cielo notturno, visibile da entrambi gli emisferi durante i mesi invernali. La sua posizione centrale nella costellazione di Orione la rende un punto di riferimento per individuare altre stelle e costellazioni. Interessante, ma puramente fotografico, è il Loop di Barnard, noto anche come Anello di Barnard, una nebulosa a emissione visibile nella costellazione di Orione. È una struttura a forma di anello, debole ma riconoscibile nelle foto a lunga esposizione, che circonda la regione della Cintura di Orione. Questa nebulosa è composta principalmente da idrogeno ionizzato ed è illuminata dalle stelle calde e giovani presenti nella regione. Il Loop di Barnard è un esempio di regione di formazione stellare attiva e contribuisce alla complessa e affascinante struttura della costellazione di Orione.
Orione si trova tra Toro e Gemelli e domina il cielo invernale, passando in meridiano a mezzanotte pochi giorni prima di Natale. Proprio da Orione è possibile orientarsi per trovare tante altre gemme celesti e questo è dovuto alla sua forma inconfondibile ed alla disposizione delle sue stelle maggiori.
E' una costellazione attraversata dall'equatore celeste, proprio nei pressi della terza stella della cintura, Mintaka. Si tratta forse della costellazione più bella di tutta la volta celeste, visibilissima dai due emisferi proprio perché costellazione equatoriale: per gli osservatori europei Orione è alta a sud dopo il tramonto, per quelli australiani è alta verso nord.
I corpi celesti
Orione è una costellazione molto ricca, sia per corpi stellari che di altro tipo.
Ci sono ben sette stelle molto luminose che caratterizzano proprio la forma del guerriero. Tra queste, Rigel è la più brillante pur non essendo la stella alpha. Quindi, Betelgeuse è la stella alpha e Rigel la stella beta.
La cintura è formata da tre stelle abbastanza luminose, di nome Alnitak, Alnilam e Mintaka. Ovviamente neanche le stelle di Orione, così come quelle della grande maggioranza delle costellazioni, sono accomunate da qualcosa se non dall'appartenenza a questa costellazione:
Le stelle di Orione sono davvero molto distanti, tanto che anche il loro moto proprio risulta molto piccolo. Ciò nonostante, la forma di Orione non sarà la stessa tra un milione di anni, e non era tale un milione di anni fa quando la stella più brillante era Saiph (che oggi è la meno conosciuta): brillava più di quanto brilla oggi Venere e si trovava nell'emisfero Nord mentre oggi la sua declinazione è ampiamente a Sud.
Tra i corpi non stellari, la nebulosa di Orione è la più famosa dell'intero cielo. In realtà è formata da due nebulose molto vicine, M42 ed M43. Al loro interno c'è un gran proliferare di nuove stelle, molte delle quali presentano dei dischi protoplanetari. All'interno della nebulosa brilla Theta Orionis, un insieme di quattro stelle note come Trapezio per la forma assunta.
Più piccola, invece, è M78. Nei pressi della cintura, inoltre, è presente anche la nebulosa IC 434, al cui interno la parte scura è nota come nebulosa 'Testa di Cavallo' e sotto la quale brilla la nebulosa Fiamma (NGC 2024).
Visibilita annuale di Orion
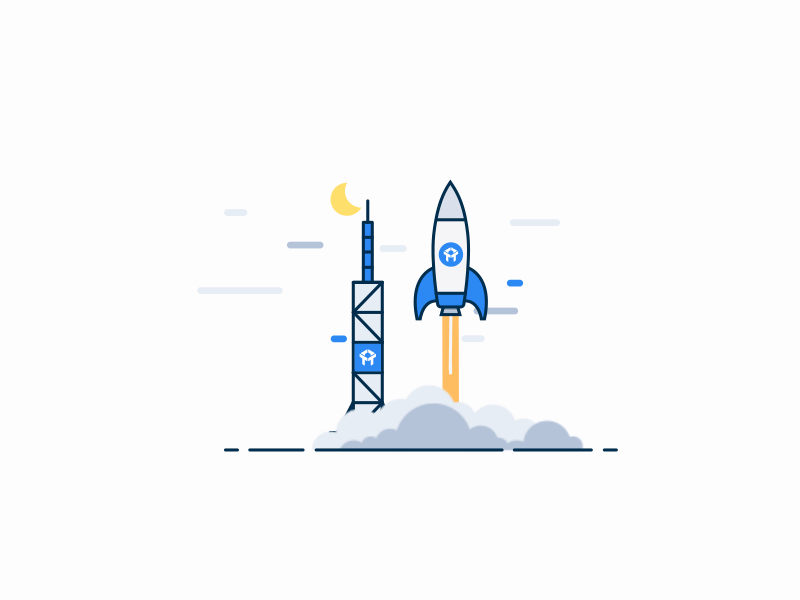

 Chi Siamo
Chi Siamo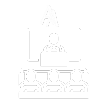 Terra in Vista 2024
Terra in Vista 2024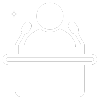 Relatori
Relatori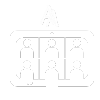 Argomenti
Argomenti WebTV
WebTV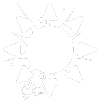 Sole
Sole Luna
Luna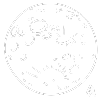 Strutture lunari
Strutture lunari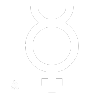 Mercurio
Mercurio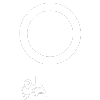 Venere
Venere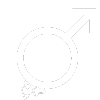 Marte
Marte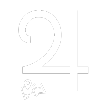 Giove
Giove Satelliti di Giove
Satelliti di Giove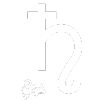 Saturno
Saturno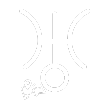 Urano
Urano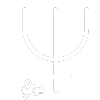 Nettuno
Nettuno Asteroidi
Asteroidi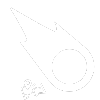 Comete
Comete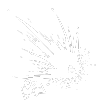 Bolidi
Bolidi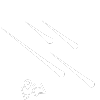 Sciami meteorici
Sciami meteorici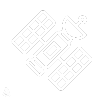 ISS
ISS Altri satelliti
Altri satelliti Lanci
Lanci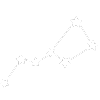 Costellazioni
Costellazioni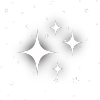 Stelle
Stelle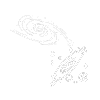 Profondo cielo
Profondo cielo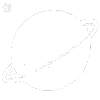 Esopianeti
Esopianeti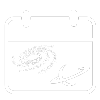 Cielo del mese
Cielo del mese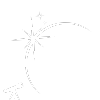 Eclissi di Sole
Eclissi di Sole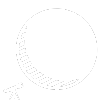 Eclissi di Luna
Eclissi di Luna